Prec Sezione 17.1: Distribuzione
binomiale per popolazione finita Su Capitolo 17:
Sistema di servizio, teoria del trafficoe delle reti Sezione
17.3: Sistema di servizio orientato alla perdita Segue
17.2 Distribuzione di Poisson
Al crescere del numero N di
utenti, l’utilizzo della distribuzione Binomiale può risultare
disagevole, per via dei fattoriali, e si preferisce trattare il numero
di conversazioni attive k come una
variabile aleatoria di poisson↓,
la cui densità di probabilità ha espressione
ed è caratterizzata da valor medio e varianza mp
= σ2P
= α. La Poissoniana costituisce una buona
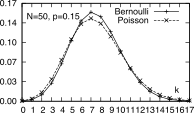 approssimazione della ddp di Bernoulli, adottando per la prima lo stesso
valor medio della seconda mP
= mB, ossia α
= Np, come mostrato in figura.
approssimazione della ddp di Bernoulli, adottando per la prima lo stesso
valor medio della seconda mP
= mB, ossia α
= Np, come mostrato in figura.
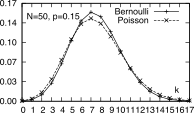
Più in generale, questa densità è impiegata per
descrivere la probabilità che si verifichino un numero di eventi indipendenti
e completamente casuali↓
di cui è noto solo il numero medio α( [841] [841] Usando il modello Poissoniano
pertanto, la probabilità che (ad esempio) si stiano svolgendo meno
di 4 conversazioni contemporanee è pari a pP(0) + pP(1) + pP(2) + pP(3) = e
− α⎛⎝1 + α
+ (α2)/(2) + (α3)/(6)⎞⎠.).
D’altra parte, al tendere di N ad
∞ il modello Bernoulliano adottato finora
perde di validità. Infatti, nel caso di una popolazione infinita, il
numero di nuove chiamate non diminuisce all’aumentare del numero
dei collegamenti in corso. In questo caso, gli eventi corrispondenti
all’inizio di una nuova chiamata sono invece considerati indipendenti
e completamente casuali, e descritti unicamente in base ad una frequenza
media di interarrivo↓ λ che rappresenta la velocità [842] [842] λ viene espresso in richieste
per unità di tempo. con cui si presentano le
nuove chiamate [843] [843] La
trattazione può facilmente applicarsi a svariate circostanze: dalla
frequenza con cui si presentano richieste di collegamento ad una
rete di comunicazioni, alla frequenza con cui transitano automobili
sotto un cavalcavia, alla frequenza con cui particelle subatomiche
transitano in un determinato volume, alla frequenza con cui gli
studenti si presentano a lezione.... L’inverso di λ rappresenta un tempo,
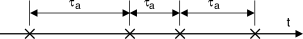 ed esattamente τa
= 1 ⁄ λ è il valor medio della variabile
aleatoria τa
costituita dall’intervallo di tempo tra l’arrivo di due chiamate.
ed esattamente τa
= 1 ⁄ λ è il valor medio della variabile
aleatoria τa
costituita dall’intervallo di tempo tra l’arrivo di due chiamate.
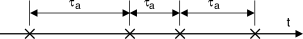
Tempi
di Interarrivo
Con queste definizioni, è possibile riferire la
v.a. di Poisson ad un intervallo temporale di osservazione T,
durante il quale si presentano un numero medio α
di chiamate [844] [844] Esempio:
se da un cavalcavia osserviamo (mediamente) λ
= 3 auto/minuto, nell’arco di T
= 2 minuti, transiteranno (in media) 3*2 = 6 autovetture.
pari a α = λT.
Pertanto, possiamo scrivere la ddp della v.a. Poissoniana come
pP(k)|T = e − λT((λT)k)/(k!)
che indica la probabilità che in un tempo T
si verifichino k eventi
(indipendenti e completamente casuali) la cui frequenza media è λ( [845] [845] Esempio: sapendo che
l’autobus (completamente casuale!) che stiamo aspettando ha una
frequenza di passaggio (media) di 8 minuti, calcolare: A) la
probabilità di non vederne nessuno per 15 minuti e B) la
probabilità che ne passino 2 in 10 minuti.
Soluzione: si ha λ
= 1 ⁄ 8 passaggi/minuto e quindi: A) pP(0)|15
= e − (15)/(8)
= 0.15 pari al 15%; B) pP(2)|10
= e − (10)/(8)(⎛⎝(10)/(8)⎞⎠2)/(2) = 0.224 pari al
22.4%
). 17.2.1 Variabile aleatoria esponenziale negativa↓
La descrizione statistica che la ddp di Poisson
fornisce per il numero di eventi che si verificano in un
(generico) tempo t, è strettamente
legata al considerare questi come indipendenti, identicamente
distribuiti, e per i quali l’intervallo di tempo tra
l’occorrenza degli stessi è una determinazione di variabile aleatoria completamente
casuale [846] [846] Da un
punto di vista formale, per eventi completamente casuali si
intende che gli eventi stessi non hanno memoria di quando
siano accaduti l’ultima volta, permettendo quindi di scrivere
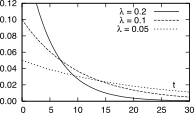 σ2E = (1)/(λ2).
La probabilità che il tempo di attesa di una v.a. esponenziale superi un
determinato valore t0,
è allora calcolabile come
e questo risultato ci permette di verificare il legame con la
Poissoniana [849] [849] Consideriamo
un ospedale in cui nascono in media 6 bimbetti al giorno (o
0.25 nascite l’ora), e consideriamo
l’intervallo tra questi eventi come una v.a. completamente casuale.
Se assumiamo che la probabilità di k
nascite in un tempo T sia
descritta da una v.a. di Poisson, ossia a cui compete una
probabilità pP(k) =
e − λT((λT)k)/(k!),
allora la probabilità che durante un tempo T
non avvenga nessuna nascita, dovrebbe corrispondere a calcolare pP(0),
ovvero e − λT((λT)0)/(0!) = e − λT,
che è esattamente il risultato che fornisce la v.a. esponenziale per
la probabilità Pr(t
> T) che non vi
siano nascite per un tempo T..
σ2E = (1)/(λ2).
La probabilità che il tempo di attesa di una v.a. esponenziale superi un
determinato valore t0,
è allora calcolabile come
e questo risultato ci permette di verificare il legame con la
Poissoniana [849] [849] Consideriamo
un ospedale in cui nascono in media 6 bimbetti al giorno (o
0.25 nascite l’ora), e consideriamo
l’intervallo tra questi eventi come una v.a. completamente casuale.
Se assumiamo che la probabilità di k
nascite in un tempo T sia
descritta da una v.a. di Poisson, ossia a cui compete una
probabilità pP(k) =
e − λT((λT)k)/(k!),
allora la probabilità che durante un tempo T
non avvenga nessuna nascita, dovrebbe corrispondere a calcolare pP(0),
ovvero e − λT((λT)0)/(0!) = e − λT,
che è esattamente il risultato che fornisce la v.a. esponenziale per
la probabilità Pr(t
> T) che non vi
siano nascite per un tempo T..
Pr(t
> t0 + θ ⁄ t > t0) = Pr(t
> θ)
ossia che la probabilità di attendere altri θ
istanti, avendone già attesi t0,
non dipende da t0.
Per verificare che la ddp esponenziale consente di soddisfare questa
condizione, svolgiamo i passaggi, applicando al terzultimo la (19.3↓):
Pr(t
> t0 + θ ⁄ t > t0)
= (Pr(t > t0
+ θ;t > t0))/(Pr(t > t0))
= (Pr(t
> t0 + θ))/(Pr(t > t0))
=
= (e
− λ(t0
+ θ))/(e
− λt0)
= e − λθ = Pr(t
> θ)
, descritta da una densità di probabilità esponenziale
negativa [847] [847] La ddp
esponenziale è spesso adottata come un modello approssimato ma di
facile applicazione per rappresentare un tempo di attesa, ed
applicato ad esempio alla durata di una conversazione telefonica,
oppure all’intervallo tra due malfunzionamenti di un apparato.,
espressa analiticamente come
pE(t) = λe − λt
valida per t ≥ 0, e mostrata in
figura; tale v.a. è caratterizzata dai momenti [848] [848] Per
quanto riguarda il valor medio mE
= ∫∞0tλe
− λtdt possiamo procedere per
parti, ossia applicando la regola ∫baf’(t)g(t)dt
= f(t)g(t)|ba
− ∫baf(t)g’(t)dt,
avendo posto f’(t) = e − λt
e g(t) = λt: si ottiene
allora
mE =
− (1)/(λ)e − λt⋅λt||∞0
− ∞⌠⌡0 − (1)/(λ)e − λt⋅λdt
= − 0 + 0 − (1)/(λ)e − λt||∞0
= (1)/(λ)
essendo limt → ∞e
− λt⋅λt = 0. Per σ2E = ∫∞0t2λe
− λtdt − (mE)2, il primo integrale
(sempre procedendo per parti) fornisce ∫∞0t2λe
− λtdt = (2)/(λ2), e dunque σ2E
= (2)/(λ2) − (1)/(λ2) = (1)/(λ2). mE = (1)/(λ)
e
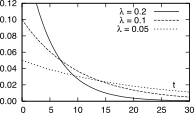
Densità
di v.a. Esponenziale
Esempio Se
la durata media di una telefonata è di 5
minuti, e la durata complessiva è completamente casuale, quale è la
probabilità che la stessa duri più di 20
minuti?
Risposta: ci viene fornito un tempo di attesa medio τa,
a cui corrisponde una frequenza di servizio λ
= (1)/(τa), e quindi la soluzione
risulta Pr(t
> 20) = ∫∞20(1)/(τa)e
− t ⁄ τadt = e
− 20 ⁄ 5 = 0.0183 = 1.83%.
Un corollario [850] [850] La
dimostrazione della (19.4↓)
si basa sulla considerazione che Pr(t ≤ t0)
= 1 − Pr(t > t0), e sulla espansione in serie di
potenze ex = 1 + x
+ x2⁄2 + x3⁄3!
+ ⋯ che si riduce a ex
= 1 + x + o(t0) se x
→ 0. Pertanto, la (19.3↑)
diviene Pr(t > t0)|t0
→ 0 = 1 − λt0 + o(t0), e quindi Pr(t ≤ t0)
= 1 − 1 + λt0 + o(t0) = λt0 + o(t0).
della (19.3↑)
è che, se t0 → 0,
allora la probabilità che si verifichi un evento entro un tempo t0,
è direttamente proporzionale (a meno di un infinitesimo di
ordine superiore di t0)
al valore di t0, ossia
Prec Sezione 17.1: Distribuzione
binomiale per popolazione finita Su Capitolo 17:
Sistema di servizio, teoria del trafficoe delle reti Sezione
17.3: Sistema di servizio orientato alla perdita Segue
 Nato più di 20 anni fa, un progetto di
Nato più di 20 anni fa, un progetto di