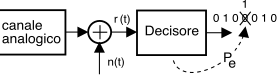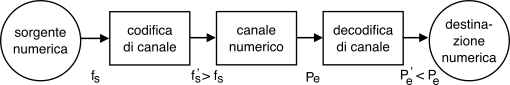1.2 Segnali analogici e numerici
Gli aspetti accennati sono immediatamente applicabili a segnali di natura
analogica, definiti per
tutti gli istanti di tempo, e che assumono valori nell’ambito dei numeri reali (o, come vedremo al cap.
11, complessi), come ad esempio nel caso di un segnale audio (vocale o musicale); d’altra parte, un segnale può viceversa essere definito solo per istanti di tempo
discreti ovvero numerabili, ed assumere valori anch’essi discreti, come ad esempio per i documenti conservati su di un computer. In tal caso il segnale viene detto
sequenza numerica, e la sua trasmissione coinvolge ulteriori elementi.
La figura
1.3 illustra la classificazione dei segnali dal punto di vista analitico, in base all’insieme di definizione dei valori assunti, e del dominio a cui appartiene la variabile indipendente.
Notiamo che oltre ai due casi di segnale analogico e sequenza numerica, sussistono anche i due casi intermedi di
segnale quantizzato sq(t) definito per tutti gli istanti ma a valori discreti, e di sequenza di campioni s•n definita ad istanti discreti, ma con valori continui. La relazione tra queste rappresentazioni dell’informazione viene approfondita al § 1.2.2. 1.2.1 Segnale analogico
Corrisponde all’andamento
nel tempo di una grandezza fisica
s(t), di natura elettromagnetica come nei campi dell’elettronica o dei circuiti, ovvero risultato della trasduzione elettrica di grandezze di altra natura, come nel caso di un segnale audio che consiste in un’onda trasversale di pressione-velocità convertita in una tensione da un microfono, o nel caso di una misura di posizione, velocità od accelerazione ottenuta mediante tecniche di geo-localizzazione come nel telerilevamento, oppure ancora acquisita mediante sensori utilizzati ad es. nel contesto dei sistemi di controllo automatico.
Una diversa categoria di segnale sono le
immagini, definite come una funzione di due variabili
spaziali s(x, y) il cui valore ne individua la
luminanza, eventualmente corredata da altri segnali di immagine definiti sullo stesso dominio e relativi all’informazione di
crominanza. In questo contesto il fattore
tempo torna in gioco qualora si tratti di immagini in movimento, come nei video: questi aspetti sono trattati al cap.
10.
Un segnale può anche presentare
valori complessi, e in tal caso
si sdoppia in due andamenti definiti come parte reale e parte immaginaria, oppure modulo e fase. In tutti casi, un segnale analogico corrisponde alla comune accezione di funzione di variabile continua dell’analisi matematica, definita su di un supporto che può essere limitato o meno, e può in generale essere studiato e caratterizzato con le tecniche proprie di tale disciplina. Al §
1.5 è fornita una classificazione dei segnali in categorie (impulsivi, di energia, di potenza, e periodici) che rivestono un ruolo fondamentale per il loro studio successivo.
1.2.1.1 Rappresentazione frequenziale dei segnali analogici
Un fondamentale strumento per lo studio di un segnale
s(t) è la sua
analisi spettrale,
condotta per mezzo di una particolare
trasformazione lineare, che individua un corrispondente segnale (in generale complesso)
S(f) funzione di una diversa variabile indipendente
f nota come
frequenza. Questo nuovo segnale è un sorta di
radiografia, una analisi che individua lo
spettro di frequenze di cui è costituito
s(t); la differenza tra la minima e massima delle frequenze presenti è detta
banda del segnale, uno dei principali parametri che lo caratterizzano dal punto di vista dell’impegno delle risorse necessarie a trasmetterlo.
A seconda della categoria in cui ricade s(t), la trasformazione assume una tra diverse formulazioni, definendo così uno sviluppo in serie di Fourier per la rappresentazione dei segnali periodici, una trasformata di Fourier per segnali di energia, e uno spettro di densità di potenza per segnali di durata indefinita. L’analisi di Fourier individua come la potenza (o l’energia) del segnale si distribuisce in frequenza.
1.2.1.2 Transito dei segnali attraverso sistemi fisici
L’attraversamento di un
canale da parte di un segnale analogico, che come discusso al §
1.1 avviene grazie ad un
mezzo trasmissivo, viene studiato mediante l’ausilio di alcuni strumenti fondamentali qui brevemente descritti, e ripresi al §
1.6.
Risposta impulsiva e convoluzione
La prima rappresenta l’uscita di un sistema fisico quando in ingresso è presente una particolare astrazione analitica, detta
impulso di Dirac. La risposta impulsiva permette di esprimere l’uscita del sistema in corrispondenza di un ingresso qualunque, mediante il calcolo di un particolare integrale (
di convoluzione) che coinvolge solamente l’espressione del segnale in ingresso, e quella della risposta impulsiva.
Risposta in frequenza e filtraggio
Operando nel dominio della frequenza, osserveremo come la trasformata di Fourier della risposta impulsiva rappresenti la
risposta in frequenza del sistema, ovvero la modalità con cui il sistema riproduce in uscita ciascuna delle frequenze presenti nel segnale di ingresso. Dato che la risposta in frequenza descrive quali frequenze passeranno amplificate, inalterate od attenuate, il transito di un segnale viene indicato anche con il termine
filtraggio, ed il sistema è detto
filtro.
Qualora il canale (o filtro) attraverso cui convogliare il segnale
s(t) non permetta l’attraversamento alle frequenze in esso presenti,
come ad esempio nel caso di un collegamento radio, occorre trasformare il segnale mediante una tecnica chiamata
modulazione, in modo che il risultato giaccia in una
banda di frequenze compatibile con la risposta in frequenza del canale. Il segnale modulato occupa ora una banda concentrata attorno ad un frequenza più elevata detta
portante, ed il suo andamento nel dominio del tempo è descritto da un segnale noto come
inviluppo complesso.
Nel caso di collegamenti a distanza il mezzo trasmissivo
attenua il segnale in transito, che viene ricevuto con una ampiezza molto inferiore a quella di trasmissione. Pertanto è fondamentale verificare che la potenza ricevuta non sia inferiore alla
soglia di sensibilità del ricevitore, ovvero il minimo segnale necessario a garantire la qualità di ricezione richiesta. D’altra parte, attenuazioni e distorsioni di entità non trascurabile possono verificarsi anche in assenza di collegamenti a distanza, qualora si verifichi un
disadattamento di impedenza tra stadi della catena trasmissiva.
Ulteriori aspetti dei sistemi di telecomunicazione sono riassunti al §
1.4, mentre ora ci occupiamo di caratterizzare le modalità di trasmissione per una
sequenza.
1.2.2 Trasmissione numerica
Quando il contenuto informativo è costituito da una sequenza numerica
sn i suoi elementi possono essere messi in relazione biunivoca con un più generale
alfabeto simbolico A a cardinalità finita, come ad esempio nel caso di un testo scritto, in cui
A è il vero e proprio alfabeto della lingua in cui è scritto il testo. In questo caso sorgente e destinazione della trasmissione sono anch’esse indicate come
numeriche, mentre gli elementi della sequenza
sn sono indicati come
simboli, emessi dalla sorgente ad intervalli temporali regolari distanziati da un tempo di
Ts secondi detto
periodo di simbolo, il cui inverso
fs = 1⁄Ts è indicato come
frequenza di simbolo. Ciò che permette la trasmissione tra sorgente e destinazione dell’informazione contenuta nel messaggio prende ora il nome di
canale numerico , pensabile come una entità a sé stante, che la figura seguente mostra essere comunque costituito al suo interno dal canale
analogico già discusso, e basato a sua volta su di un mezzo trasmissivo.
Modem o codificatore di linea
Denota il dispositivo che provvede a generare un segnale analogico s(t) in grado di trasportare l’informazione espressa dalla sequenza numerica sn, e la cui etimologia deriva dalla contrazione di modulatore e demodulatore, mentre il termine codificatore di linea è riferito alla trasmissione su di una linea di trasmissione come ad esempio un collegamento in cavo. In particolare, una trasmissione unidirezionale necessita di solo metà delle funzioni del modem per entrambi i lati del collegamento, mentre nel caso di collegamento full duplex (in cui gli estremi del canale possono essere contemporaneamente sorgente e destinazione) il modem opera allo stesso tempo nelle due direzioni.
All’interno del modem di ricezione è presente un dispositivo decisore, in grado di ricostruire la sequenza sn a partire dal segnale analogico ricevuto r(t), ma a causa del rumore n(t) presente all’uscita del canale analogico il decisore può commettere errore, producendo una sequenza ŝn ≠ sn.
Quando il
decisore presente nel modem produce un simbolo
diverso da quello trasmesso si verifica un
errore, e la frazione del numero di eventi di errore rispetto al totale rappresenta la
probabilità di errore, il cui valore costituisce il parametro che caratterizza
la qualità del collegamento numerico. Evidentemente il valore
della probabilità di errore è strettamente legato in modo inverso a quello del rapporto segnale-rumore
snr che si riscontra per il canale analogico sottostante.
Affrontiamo ora due aspetti del tutto peculiari della trasmissione di sequenze numeriche e simboliche, ovvero la codifica di canale e di sorgente.
Consiste nell’invio di più simboli di quanti non ne produca la sorgente, e quindi di fatto
aumentando il loro numero per unità di tempo, che da
fs passa ad
f’s > fs. La scelta dei simboli aggiunti viene fatta in modo che essi
dipendano in modo
deterministico da quelli già presenti, rendendo così la sequenza trasmessa
ridondante, allo scopo di ridurre il valore della probabilità di errore. Infatti la dipendenza (nota) tra i simboli trasmessi permette al ricevitore di "accorgersi" che si è verificato un errore, dato che tale dipendenza non è più rispettata, e quindi il ricevitore può attuare delle contromisure, come quella di inviare una richiesta di ritrasmissione, oppure se la ridondanza
introdotta è sufficientemente elevata, tentare di correggere errori isolati. Dopo aver (eventualmente) svolto le possibili contromisure, i simboli aggiunti vengono rimossi al lato ricevente da parte di un blocco di
decodifica di canale.
Ha uno scopo per così dire “inverso” a quello della codifica di canale: la codifica di sorgente infatti rimuove la dipendenza (ora in senso statistico) tra i simboli presenti nella sequenza prodotta dalla sorgente, determinando la riduzione del numero di simboli da trasmettere per unità di tempo, che passa così da fs ad f’s < fs. Un tipico esempio è rappresentato dagli algoritmi di compressione per i documenti su computer, come ad es. i file zippati: in tal caso il fattore di compressione ottenibile dipende dalla natura del file, ed è tanto maggiore quanto più questo presenti caratteristiche di ripetitività, ovvero di predicibilità del suo contenuto. Pertanto l’uscita di un codificatore di sorgente è una sequenza di simboli tendenzialmente indipendenti tra loro, avendo limitato la predicibilità di un simbolo a partire dai circostanti.
Non resta ora che discutere dei due casi elencati in fig.
1.3 ma non ancora incontrati, ovvero di
… Campionamento e quantizzazione
Poniamoci il problema di utilizzare un
canale numerico per effettuare una
trasmissione analogica: il vantaggio di una tale “contorsione” è da ricercarsi nel migliore comportamento della trasmissione numerica rispetto ai disturbi, nonché alla sua
generalità. Per riuscire nello scopo occorre che il segnale
s(t) prodotto dalla sorgente analogica venga prima
campionato prelevandone i valori
s•n in corrispondenza degli istanti
t = nTc, ossia con una velocità di
fc = 1⁄Tc campioni/secondo, e quindi
quantizzato approssimando i valori
s•n mediante un insieme finito di
L valori, producendo una sequenza numerica
sn di simboli appartenenti ad un alfabeto finito. Questa coppia di operazioni è indicata come
conversione analogico-digitale o
a/d, e la sequenza
sn può essere rappresentata da una sequenza
binaria facendo corrispondere
M = ⌈log2L⌉ bit ad ognuno dei simboli
L − ari. Dopo le operazioni di co-decodifica e trasmissione, un dispositivo di conversione
digitale-analogica (
dac) posto al lato ricevente provvede a ricostruire il segnale
s(t) originario.
L’approssimazione dei campioni
s•n mediante un insieme finito di valori introduce una
distorsione, dato che il
dac opera su valori approssimati e non su quelli reali. L’effetto risultante è come se presso la destinazione fosse presente un disturbo additivo
eq(t), detto
rumore di quantizzazione, che si somma al segnale originario. L’entità di tale disturbo è inversamente legata alla
risoluzione del quantizzatore, ovvero alla capacità di differenziare tra valori di ingresso molto vicini tra loro. In definitiva, la distorsione risulta tanto minore quanto maggiore è la velocità del flusso informativo prodotto dal quantizzatore, espresso in bit/secondo.
Abbiamo ora tutte le basi per introdurre un ulteriore concetto, quello della
Se ne parla al cap.
9, e deriva da una serie di teoremi enunciati negli anni ’50 da
Claude Shannon, le cui conseguenze possono essere riassunte come
Compromesso velocità-distorsione Una sorgente analogica campionata a velocità di
fc campioni/secondo e quantizzata con
M bit/campione produce un flusso informativo di
fb = fc ⋅ M bit/secondo, tanto più elevato quanto minore è la distorsione introdotta dal processo di quantizzazione; pertanto la velocità di trasmissione può essere ridotta a patto di accettare una maggiore distorsione.
Compromesso banda-potenza Un qualsiasi canale pone un limite al massimo flusso informativo che vi transita. Il limite deriva dai vincoli che il canale impone sulla massima banda
B del segnale trasmesso, sulla massima potenza di segnale
S ricevuta, e sulla potenza di rumore
N presente al ricevitore. Il massimo flusso di informazione in transito prende il nome di
capacità di canale C, espressa dalla relazione
C = Blog2⎛⎝1 + SN⎞⎠ bit/sec. In questi termini, la massima velocità di trasmissione può dipendere da una limitazione sulla banda, o sulla potenza, od essere causata da un eccessivo rumore: a parità di rumore solo adottando un diverso canale che permetta di trasmettere più potenza, o di occupare più banda, è possibile trasmettere a velocità più elevata.
Compromesso tempo-distorsione Considerando una coppia sorgente + canale, dato che il canale limita il massimo flusso informativo prodotto dalla sorgente, quest’ultima verrà necessariamente riprodotta con una distorsione tanto maggiore quanto minore è la capacità di canale. A meno di non cambiare canale, oppure impiegare più tempo per la trasmissione, e rinunciare alla possibilità di una riproduzione in tempo reale.